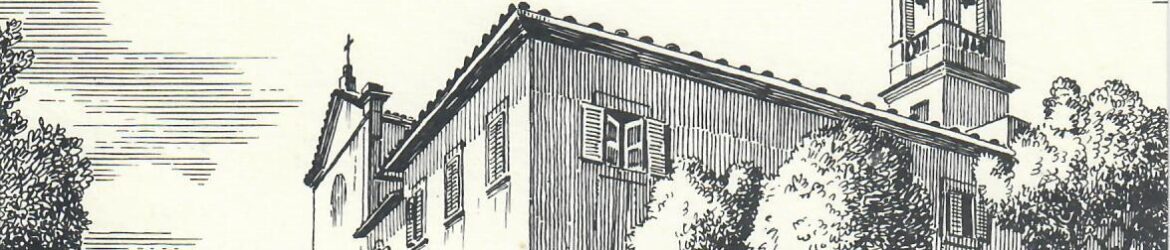di Stefano Tarocchi • Nella conclusione del recente saggio sul prefetto della Giudea (Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria, Einaudi, Torino 2016), Aldo Schiavone, giurista e storico, scrive di essere impressionato da «un’insuperabile ambiguità che si riproduce di continuo intorno a Pilato, appena se ne parli; quasi la sua cifra non potesse essere altro dall’indefinito, dalla nebbia; e aleggiasse su di lui l’ombra di un non detto, di un taciuto che intercetta ogni volta la luce, o la deforma» (143). Si tratta dell’uomo, non a caso, che Tertulliano definiva «un cristiano nel cuore» (pro sua conscientia christianus: Apologeticum, 21).
di Stefano Tarocchi • Nella conclusione del recente saggio sul prefetto della Giudea (Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria, Einaudi, Torino 2016), Aldo Schiavone, giurista e storico, scrive di essere impressionato da «un’insuperabile ambiguità che si riproduce di continuo intorno a Pilato, appena se ne parli; quasi la sua cifra non potesse essere altro dall’indefinito, dalla nebbia; e aleggiasse su di lui l’ombra di un non detto, di un taciuto che intercetta ogni volta la luce, o la deforma» (143). Si tratta dell’uomo, non a caso, che Tertulliano definiva «un cristiano nel cuore» (pro sua conscientia christianus: Apologeticum, 21).
Pilato viene raccontato in cinque intensi capitoli dal Schiavone: 1) In una notte nel mese di Nisan; 2) La Giudea romana e il lavoro del quinto prefetto; 3) Dio e Cesare; 4) Il destino del prigioniero; 5) Nell’ombra.
A parte il breve capitolo finale, che fa pendant con la stringata introduzione, il percorso segue il cammino tracciato dai Vangeli, con l’eccezione del capitolo 3: una preziosa digressione sul ruolo del prefetto della Giudea e di Pilato in questo ruolo.
Tuttavia nessuna meraviglia se l’uomo che fu, sotto il principato di Tiberio, il quinto prefetto della Giudea, in carica dal 26 al 36 d.C. (e che aveva a disposizione un’unità di cavalleria e cinque coorti di cavalleria), non era molto amato nella terra di sua pertinenza. Peraltro anche se Tacito, usando un felice anacronismo lo chiama “procuratore”, il titolo di prefetto è testimoniato un ritrovamento di una iscrizione – usata originariamente per una delle torri del porto di Cesarea Marittima, sua residenza insieme al grosso della guarnigione, dedicata all’imperatore Tiberio, e poi riutilizzata nel rifacimento del teatro della città. Una lettera del re Erode Agrippa I (in Filone, Legatio ad Caium, 38) lo descrive come «implacabile, senza riguardi, ostinato». Sappiamo anche di stragi fatte compiere dai suoi soldati tra le folle: una, in occasione dei lavori dell’acquedotto del tempio di Gerusalemme, che Pilato voleva finanziare con il tesoro del Tempio (Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche, XVIII, 3, 2); un’altra in circostanze ignote, come rammenta il terzo Vangelo (Lc 13,1: «quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici»), una terza a danno dei Samaritani, che si accompagna a quando, con le insegne imperiali e l’effige dell’imperatore, oltre che il suon nome divino, fece ingresso nel tempio di Gerusalemme. L’azione contro i Samaritani segnò la sua rovina: essi infatti reclamarono presso Vitellio, legato romano in Siria (per lui c’erano a disposizione quattro legioni: la VI, la X [Fretensis], la III e la XII) da cui Pilato dipendeva, e questi lo sospese dalla sua carica, inviandolo a Roma a rispondere del suo operato al tribunale di Tiberio. Prima che arrivasse a Roma Tiberio era già morto, e Pilato cadde nell’oblio.
Più che mai sembra decisiva la distinzione dell’autore tra storia e memoria: la memoria religiosa (ma anche culturale) «è più orientata al significato e alla comprensione degli eventi cui allude … che alla registrazione del passato in quanto tale». Questo perché la stessa memoria è la generatrice del percorso che conduce alla ricostruzione storica. Lo storico perciò distingue, tra i nomi: per lui Giuda e Barabba sono per sé solo figure della “memoria” che ci ha dato i Vangeli. Gli altri sono totalmente personaggi della storia: Anna, Caifa, Erode Antipa, Giuseppe di Arimatea, e soprattutto Pilato.
Ma la storia di Pilato può essere ricostruita solo a partire dalle testimonianze evangeliche dei tre Vangeli Sinottici, e soprattutto di Giovanni, nei rispettivi racconti della passione.
Tutte le fonti confermano che «l’arresto e la condanna di Gesù avevano avuto un impulso giudaico, all’interno dell’élite sacerdotale» (p. 72): l’autorità romana e quella giudaica hanno proceduto fianco a fianco. Questo è confermato dal fatto che nelle accuse mosse Gesù ci fu uno slittamento dal piano religioso a quello politico, che prevedeva il ben noto principio dell’autonomia delle regioni amministrate da Roma (suis moribus legibusque suis uti). Così il Vangelo di Giovanni: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!» (Gv 18,31) e l’apodittico: «noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio» (Gv 19,7).
Pilato venne usato per costringerlo a ratificare la condanna già stabilita dai maggiori esponenti del giudaismo: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette contro Cesare» (Giovanni 19,12). Era questo l’unico motivo per portare Gesù alla morte, senza invocare poter invocare a Gerusalemme la Lex Iulia maiestatis che a Roma puniva chi avesse voluto sostituirsi al potere costituito proclamandosi «re dei Giudei».
Ma Gesù, pur accusato di essere re, non ha un regno in questo mondo (cf. Giovanni 18,36). Schiavone indulge al vezzo di fare un po’ di teologia (pp. 86-87), e, per affermare il monoteismo, costruisce quasi una natura “binitaria” di Gesù, in bilico tra lui e il Padre: l’unico punto, a mio avviso, discutibile del saggio, che richiama un altro elemento binario, Dio e Cesare, e quindi la lotta dei discepoli di Cristo contro il potere del cesare di turno.
Schiavone smonta anche la memoria trasmessa dal solo Matteo del gesto per cui Pilato è giustamente famoso, l’atto di lavarsi le mani (Matteo 27,24), che a suo avviso diventa «il punto zero nella genealogia dell’antisemitismo cristiano» (p. 111), per approfondire il racconto del famoso “processo”, che l’autore nega fosse un procedimento vero e proprio, con una precisa procedura. Schiavone ha forti dubbi anche sull’invio da Pilato ad Erode, l’Antipa, come narra Luca (23,6-12), che vorrebbe addirittura costruire un’amicizia di comodo fra il tetrarca e il prefetto.
Del resto non era un processo nemmeno l’interrogatorio davanti ad Anna e poi a Caifa. Davanti a Pilato non c’era un cittadino romano, che poteva invocare una garanzia dovuta al suo stato giuridico o al suo patrimonio: c’era solo un predicatore dalle umili origini. Questo non impedisce di frapporre fra Gesù e Pilato la celebre domanda «che cos’è la verità», la cui analisi lascia trasparire anche in Schiavone una certa simpatia per il prefetto, al pari di Tertulliano e della chiesa Ortodossa Etiope che annovera Pilato tra i santi, per quest’ultimo, evidentemente affascinato dall’uomo che ha davanti (“quid est veritas?” “Est vir qui adest).
Schiavone parimenti insiste sul fatto che non solo Giovanni, ma anche Matteo e Marco finiscono per incolpare l’intero popolo ebraico dell’intera responsabilità del crimine (p. 113), scagionando (soprattutto Marco!) Pilato e il potere di Roma da ogni responsabilità sulla morte di Gesù. Se il Giudaismo ha manovrato perché Pilato pronunci la condanna, nonostante il tentativo in extremis di far appello alla consuetudine di liberare un prigioniero, non è il Giudaismo delle folle e del popolo, pur richiamate nella narrazione ma quello dell’intellighenzia del potere politico-religioso. Tutto sommato anche Pilato, nella sua ineffabile ambiguità, ne è ugualmente vittima.