Gesù e i suoi familiari
Il Mantello della Giustizia – Luglio 2024
Nel Vangelo di Marco, subito dopo la scelta dei Dodici dal gruppo di tutti i discepoli e dalla folla, l’evangelista apre un nuovo percorso: «in quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi [lett.: “quelli da parte di lui”], sentito, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé» (Mc 3,20-21).
Viene messa così in rilievo la sostanziale incomprensione dell’azione di Gesù, come si esprime nel compito affidato ai Dodici, oltre alla loro primaria, sotto ogni profilo, vicinanza al Signore: «per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni» (Mc 3,14-15). È probabilmente questo fatto che desta una reazione così drammatica nei confronti di Gesù, proprio ad opera di coloro che sono più vicini a lui, o credono di esserlo a motivo di parentela.
Dal testo del Vangelo, si muove un percorso che mette in luce una interpretazione totalmente negativa del suo agire, ancor più della precedente. Tutto questo ad opera di un altro gruppo, che non ha nulla a che fare con l’origine familiare di Gesù. Infatti, così leggiamo: «gli scribi», definiti senza mezzi termini come coloro «che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni» (Mc 3,22).
Non dobbiamo stupirci dell’ingresso nel vangelo di Marco di questo gruppo, espressione dell’ambiente di Gerusalemme e non della Galilea, ma il racconto è perfettamente coerente con ciò che l’evangelista ci dice in precedenza, esattamente dopo che Gesù ha risanato un uomo dalla mano paralizzata (Mc 3,1-5). Ciò che annota l’evangelista è presto detto: «i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire» (Mc 3,6): un’alleanza fra centro e periferia, il tempio di Gerusalemme e i partigiani di Erode Antipa.
La risposta di Gesù a quanti interpretano la sua azione contro il demonio in chiave totalmente negativa è estremamente eloquente, direi quasi di una chiarezza cristallina: «se un regno è diviso in sé stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in sé stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro sé stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito» (Mc 3,24-26). Quella interpretazione totalmente negativa dell’azione di Gesù è stigmatizzata attraverso un detto tranchant: «chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna» (Mc 3,29).
L’affermazione di Gesù sembra riposare sul senso più drammatico della ribellione contro di lui: «posseduto da uno spirito impuro» (Mc 3,30). Il che è come dire che Gesù libera l’uomo dallo spirito del male perché egli stesso ne è abitato.
Ma il Vangelo torna nuovamente laddove era partito. Sembra quasi che il narratore voglia spiegare di nuovo quell’atteggiamento descritto nel brano iniziale, chiamando in causa la madre – l’unica volta in tutto il Vangelo di Marco! – e i fratelli di Gesù: «giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre» (Mc 3,31-35).
Tuttavia, in questo caso i familiari di Gesù non parlano né esprimono alcun giudizio su di lui: sarebbe inconcepibile davanti alla presenza della madre e dei familiari più stretti, così come il Vangelo li designa. E invece Gesù che parla e coglie l’occasione di spostare quel dibattito sul senso della sua missione verso un profilo molto più alto: «chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre» (Mc 3,35). L’evangelista sembra dire che accettando il disegno divino, la sua volontà e soltanto quella, si supera la stessa dimensione della parentela umana, descritta in crescendo nel passaggio da fratello e sorella a madre.
Tutto ciò significa accettare la missione di Gesù e il suo significato attraverso l’agire concreto verso quanti egli incontra, da coloro che egli guarisce dai mali fisici a quanti libera dallo spirito del male.
Questa narrazione estremamente efficace, il cui stile narrativo “mosso” ritroveremo più avanti nell’episodio della bambina di Giàiro, riportata in vita dalla morte che sembrava averla afferrata (Mc 5,22-24.35-43), al cui interno si intreccia il racconto della donna affetta da emorragia (Mc 5,25-34), apre lo sguardo a una comunicazione che stupisce per la sua modernità: la perenne novità del Vangelo.
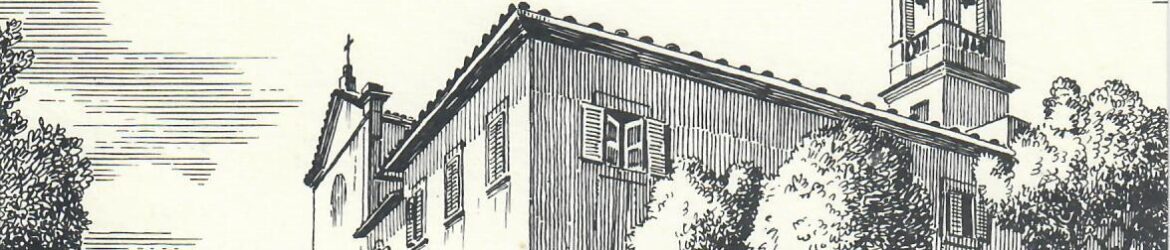
 di Stefano Tarocchi · Il tema della croce di Gesù Cristo, che è centrale in questo tempo di Pasqua, è uno dei temi più diffusi, e al tempo stesso meno conosciuti, dell’annuncio cristiano.
di Stefano Tarocchi · Il tema della croce di Gesù Cristo, che è centrale in questo tempo di Pasqua, è uno dei temi più diffusi, e al tempo stesso meno conosciuti, dell’annuncio cristiano.