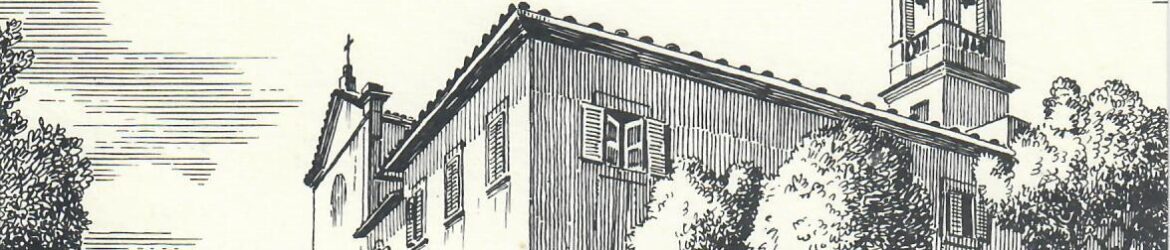di Stefano Tarocchi • «Ogni traduzione, anche la più accurata, anche quella che più si preoccupa di rendere il senso genuino dei testi originali, è pur sempre un’“interpretazione”, una serie di scelte esegetiche, legate per forza alla sensibilità, alla formazione culturale, alle preferenze» di quanti vi si accingono. Così scriveva l’arcivescovo Florit in una premessa rimasta inedita della traduzione della CEI del 1971.
di Stefano Tarocchi • «Ogni traduzione, anche la più accurata, anche quella che più si preoccupa di rendere il senso genuino dei testi originali, è pur sempre un’“interpretazione”, una serie di scelte esegetiche, legate per forza alla sensibilità, alla formazione culturale, alle preferenze» di quanti vi si accingono. Così scriveva l’arcivescovo Florit in una premessa rimasta inedita della traduzione della CEI del 1971.
Il concilio Vaticano II aveva detto: «È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla sacra Scrittura. Per questo motivo, la Chiesa fin dagli inizi fece sua l’antichissima traduzione greca del Vecchio Testamento detta dei Settanta, e ha sempre in onore le altre versioni orientali e le versioni latine, particolarmente quella che è detta Volgata. Poiché, però, la parola di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo, la Chiesa cura con materna sollecitudine che si facciano traduzioni appropriate e corrette nelle varie lingue, di preferenza a partire dai testi originali dei sacri libri» (Dei Verbum22).
Negl’intendimenti di Florit nella fase immediatamente postconciliare, la nuova traduzione della Bibbia in lingua italiana, o piuttosto la revisione di quella curata da Galbiati, Penna e Rossano, doveva essere riversata prevalentemente nella liturgia e doveva avere le seguenti caratteristiche: 1. che fosse, quanto possibile, esatta nel rendere il testo originale; 2. che avesse una sua modernità di linguaggio ed una eufonia della frase per favorire la proclamazione nelle assemblee; 3. che fosse curata nel ritmo, secondo le esigenze della recitazione e del canto».
Nella sostanza, con «un vocabolario, quanto più possibile, moderno e vivo, un periodare abbastanza agile e spezzato» ottenuto con «la purificazione del testo da eventuali sviste e da asprezze lessicali e sintattiche».
Florit manifesta la preoccupazione «attraverso, la revisione letteraria, di giungere ad un testo corretto e apprezzabile dal punto di vista linguistico» e che deve «lasciare intatte le scelte di carattere interpretativo fatte dai biblisti», che avendo un «compito prevalentemente di natura esegetica e teologica» hanno «potuto occuparsi solo di riflesso dell’aspetto linguistico».
Il compito dei «letterati fiorentini», voluti da Florit e dai suo collaboratori (si tratta di Chiari, Lisi, Betocchi, Bargellini, Devoto, Pieraccioni, Pampaloni, Paolo Sacchi, L.M. Personé, e Carlo Bo), è stato quello di eliminare le forme arcaiche, i «semitismi di difficile comprensione, i periodi eccessivamente lunghi», tipici dell’epistolario paolino. Nella lettera loro indirizzata Florit scriverà espressamente che la «terza fase del lavoro, per quanto si riferisce al Nuovo Testamento, si vorrebbe realizzare a Firenze, tenuto conto dell’opportunità di “risciacquare i panni in Arno”».
L’arcivescovo di Firenze era saggiamente consapevole che «l’opera non [avrebbe potuto] soddisfare tutte le esigenze». Perciò Florit mostra di gradire, anzi solleciterà «rilievi, annotazioni, critiche… tali da permettere «nelle future edizioni gli opportuni miglioramenti sia dal punto di vista interpretativo che linguistico».
Firenze inevitabilmente assume un ruolo decisivo, ma nel quadro di una oralità che renda il testo sempre più coinvolgente, dopo la lunga stagione di estraneità dei credenti davanti alla Vulgata. Questo era possibile nell’orizzonte letterario del tempo, sia per l’importanza di quanti erano stati chiamati a condividere il progetto, sia per il quadro culturale che scaturiva dalla città. La lingua italiana di quaranta anni fa era Firenze e la Toscana, prima che il linguaggio televisivo e i suoi influssi romani e lombardi creassero un’altra stagione, e un altro tipo di lingua, una lingua comune forse non migliore ma certo diversa.
Secondo le intenzioni di Florit non si traduce la Bibbia solo far comprendere il testo a chi non conosce il greco e l’ebraico – esistevano già eccellenti traduzioni in lingua italiana –, ma perché la proclamazione nell’assemblea ridia nuovo vigore alla parola, al pari dell’interprete di uno spartito musicale che trasmette a quanti ascoltano la forza della parola. L’interprete può leggere lo spartito musicale, come si distende nella sua mente, dopo che si trova sul pentagramma davanti ai suoi occhi: finché rimane in questo stadio la Parola rivelata non comunica a nessuno la sua verità, che è fatta di suono vivo ed efficace anche in una traduzione. L’interprete, come il traduttore, ha il compito di far risuonare la parola nel cuore e nella mente di quanti ascoltano.
Siamo in sostanza all’orizzonte determinato dalla lettura pubblica della Parola, in quella duplice mensa che questa condivide con il pane della vita, l’Eucaristia, in sintonia con il libro di Neemia: «Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle Acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge» (Neemia 8,1-3).
Come dice il Vangelo di Luca: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Luca 4,21)»