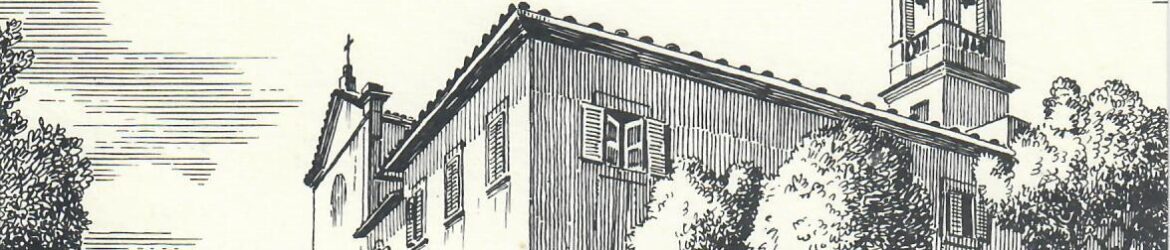di Stefano Tarocchi • La recente visita del papa Francesco ad Istanbul, dal patriarca ecumenico Bartolomeo, in occasione della festa di S. Andrea, il 30 novembre scorso, è solo l’ultimo di una serie di incontri fra i due. Cominciò Bartolomeo per l’inizio del ministero petrino di Francesco, la prima volta che un patriarca ecumenico, partecipava di persona a tale evento. Poi l’incontro nel viaggio di Francesco a Gerusalemme, lo scorso maggio, seguito a breve dalla partecipazione alla preghiera indetta da Francesco per la pace in Medio Oriente con Abu Mazen e Shimon Perez, ma anche dalla presenza a Roma per la festa dei Santi Pietro e Paolo.
di Stefano Tarocchi • La recente visita del papa Francesco ad Istanbul, dal patriarca ecumenico Bartolomeo, in occasione della festa di S. Andrea, il 30 novembre scorso, è solo l’ultimo di una serie di incontri fra i due. Cominciò Bartolomeo per l’inizio del ministero petrino di Francesco, la prima volta che un patriarca ecumenico, partecipava di persona a tale evento. Poi l’incontro nel viaggio di Francesco a Gerusalemme, lo scorso maggio, seguito a breve dalla partecipazione alla preghiera indetta da Francesco per la pace in Medio Oriente con Abu Mazen e Shimon Perez, ma anche dalla presenza a Roma per la festa dei Santi Pietro e Paolo.
Bartolomeo ha commentato l’incontro del 30 novembre come «un fatto storico e ricco di buoni auspici per il futuro. Esso costituisce un ulteriore tassello nel ponte tra Occidente e Oriente costruito poco a poco dalle visite di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI». E ha aggiunto sottolineando la testimonianza della volontà Vostra del papa e della «Santissima Chiesa di Roma, di proseguire il fraterno costante cammino con la nostra Chiesa Ortodossa, per il ristabilimento della completa comunione tra le nostre Chiese».
Lo stesso desiderio è espresso da Papa Francesco nella stessa celebrazione quando, con animo colmo di gratitudine, dice che «Dio mi concede di trovarmi qui a pregare insieme con Vostra Santità e con questa Chiesa sorella». «Il Signore ci ha donato ancora una volta il fondamento che sta alla base del nostro protenderci tra un oggi e un domani, la salda roccia su cui possiamo muovere insieme i nostri passi con gioia e con speranza».
E «sento – afferma Francesco – che la nostra gioia è più grande perché la sorgente è oltre, non è in noi, non è nel nostro impegno e nei nostri sforzi», ma «nel comune affidamento alla fedeltà di Dio». «Questa pace, questa gioia, il mondo non la può dare – sottolinea il Papa – invece il Signore Gesù l’ha promessa ai suoi discepoli, e l’ha donata loro da Risorto.
«Andrea e Pietro hanno ascoltato questa promessa – prosegue il Santo Padre -, hanno ricevuto questo dono. Erano fratelli di sangue, ma l’incontro con Cristo li ha trasformati in fratelli nella fede e nella carità. E in questa sera gioiosa, in questa preghiera vorrei dire soprattutto: fratelli nella speranza».
La radice di questa affermazione del papa sta nel testo del Vangelo secondo Giovanni, caro alla chiesa orientale, che così racconta la chiamata di Pietro ad opera del fratello Andrea, chiamato dal Signore prima di lui: «Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro (Gv 1,40-42). E appunto Andrea è chiamato il “protóclito”, ossia il “primo chiamato” come lo ebbe a definire lo stesso papa emerito ancora nel giugno 2006.
Questa sorta di primogenitura della chiamata, che muove Andrea, insieme ad un altro discepolo che resta anonimo nel racconto del Vangelo di Giovanni (lo stesso autore?), dalla sequela di Giovanni il Battista a quella di Gesù, è indirizzata alla chiamata di Simone. Il racconto del Quarto vangelo è assai diverso da quello della tradizione sinottica (vedi Mc 1,16-20), in cui è Gesù stesso a chiamare alla sua sequela due coppie di fratelli, Pietro e Andrea, appunto e Giacomo e Giovanni.
Gli eventi di queste ultime settimane sono a dirci che Pietro è andato da Andrea, nella speranza che i due possano «essere fratelli nella speranza del Signore Risorto!». Così, colmo di «gratitudine e trepidante attesa», il papa conclude l’indirizzo di risposta augurando a Bartolomeo e alla Chiesa di Costantinopoli il “fraterno” augurio per la festa del Santo Patrono. In cambio chiede – inaspettatamente – «il favore di benedire me e la Chiesa di Roma», chinando il capo in attesa che il “fratello” gli imponga le mani. E Bartolomeo, senza esitazioni, gli dona affettuosamente un bacio sulla testa. Il fratello ha chiamato il fratello sulla via della sequela di Gesù; il fratello accoglie il fratello sulla strada della comunione.
Se questa, fatta di gesti e di segni emblematici, è la strada per il ristabilimento di una comunione completa fra la chiesa di Roma e quella di oriente, ce lo dirà il tempo. Oggi possiamo dire che è sicuramente una delle vie su cui insiste il ministero petrino di Francesco, pur nella consapevolezza della complessità delle situazioni in cui la seconda (Istanbul) e la terza Roma (Mosca) si dibattono.